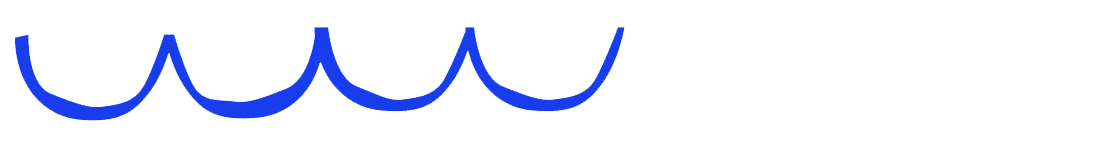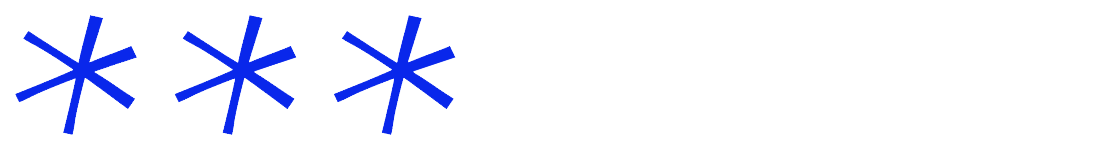Bentrovati/e 👋
Una piccola nota prima di iniziare: un anno fa usciva il mio piccolo saggio digitale per la collana Quanti di Einaudi, Al centro dei desideri. Consumo, nostalgia, estetiche digitali. Parla di centri commerciali, utopie del consumo e di come il mondo delle merci abbia contribuito alla costruzione di nuove geografie urbane e identitarie. Si legge qui 👇
La newsletter di oggi contiene un pezzo inedito e una breve di lista di letture. Ciao!
Ho visto il finale di Shameless per la prima volta due settimane fa. Ho pianto come una bambina per tutta la puntata, mentre realizzavo lentamente come la mia speranza di vedere un cameo di William H. Macy in The Bear fosse mal risposa sin dal principio, il sogno impossibile di una telespettatrice fuori sincrono. Era una fantasia che si era formata nella mia mente con naturalezza, mentre seguivo parallelamente le due serie tv facendo la spola tra una piattaforma di streaming e l’altra: mentre su Netflix recuperavo le disavventure della famiglia Gallagher e vedevo crescere il piccolo Lip, su Disney+ imparavo a conoscere Carmy Berzatto e la sua brigata di cucina. Storie diverse di due personaggi che – oltre a essere interpretati dallo stesso attore – sembravano porsi spontaneamente in continuità l’uno con l’altro.
Il desiderio di promiscuità a quel punto era diventato un istinto naturale. Mi sembrava semplicemente assurdo che un nuovo show ambientato a Chicago con protagonista Jeremy Allen White non omaggiasse lo storico show ambientato a Chicago con protagonista Jeremy Allen White. E non ero la sola a pensarlo: facendo qualche ricerca online, mi sono imbattuta in diverse teorie sui possibili riferimenti di The Bear a Shameless, ipotesi alla stregua della cospirazione a cui tuttavia ho ceduto senza resistenze, tanto era intenso in quel momento il bisogno di scorgere un legame invisibile tra le due trame.
È stato solo dopo aver trascorso un’ora della mia vita con l’orecchio incollato alle casse del computer, riavviando maniacalmente la stessa scena nel tentativo di captare il nome di Lip Gallagher in un video segnalato da un utente su reddit, che ho realizzato due cose: la prima è che la caccia alle easter eggs nei prodotti audiovisivi sta dando vita a una nuova forma di isteria collettiva, la seconda è che siamo ufficialmente entrati in un’era culturale in cui la citazione è più importante del contenuto stesso, e del contesto all’interno del quale si esprime.
Che la cultura abbia un suo modo di ricordare se stessa, di riprodursi, citarsi e riconoscersi in ogni fase del suo sviluppo è un dato implicito alla base della sua stessa sopravvivenza e della possibilità di poter sviluppare attorno a sé un senso di appartenenza e di riconoscimento attraversando epoche e geografie diverse. Al tempo stesso, la possibilità che la cultura contenga sottotesti, messaggi subliminali e codici interni è ciò che le ha permesso, nei secoli, di essere sempre più della somma delle sue parti, includendo nella sua struttura non solo il discorso dominante, ma anche tutte quelle sottoculture e controculture in grado di prosperare in maniera indipendente e decentralizzata, tracciando percorsi rizomatici discontinui, sotterranei, interstiziali. Oggi sembra di assistere a un cortocircuito di questi processi: il ricordo è incastrato nel citazionismo, le controculture si estinguono o si deformano nel reazionario, le sottoculture proliferano solo per dissolversi nel flusso transitorio delle tendenze algoritmiche.
Secondo il politologo francese Olivier Roy stiamo vivendo una periodo di deculturazione, ovvero un processo attraverso il quale un gruppo o un individuo perdono gradualmente i propri tratti distintivi e, con essi, il terreno di condivisione dei linguaggi, i costumi e le tradizioni che formano una specifica identità culturale. Non si tratta di un fenomeno nuovo, anche se – spiega Roy – la sua manifestazione contemporanea sarebbe diversa rispetto al passato: se storicamente, infatti, la deculturazione avveniva per mano di un’altra cultura dominante, che finiva per sovrapporsi alla prima, oggi stiamo assistendo a una perdita della cultura per mano di una “non-cultura” generata dai processi di atomizzazione e desocializzazione neoliberista, la sostituzione di un terreno culturale con un vuoto depersonalizzato.
C’è stato un momento in cui sembrava che la cultura dominante si stesse estinguendo per permettere lo sviluppo di un sistema multipolare, fatto di nicchie diversificate per geografia e per gusto e di una rete di sottoculture indipendenti. Oggi, però, sembra che tutto sia tornato a gravitare attorno allo stesso buco nero. La deculturazione non è un’assenza di cultura ma qualcosa di più subdolo e terrificante: è la sostituzione di un sistema culturale stratificato con uno in cui tutto giace sulla superficie, in cui il sottotesto convive – se non coincide – con il testo, la trama con la sottotrama, la cultura dominante con la sottocultura. Un gruppo di studiosi definisce questo processo iper-ottimizzazione della cultura:
Hyper-optimization represents the macro-structure of culture today, organized with the primary intent of accelerating the speed of consumption. In order to accomplish this, hyper-optimization seeks to remove all sources of friction from radical experimentation to subcultural formation to active debate from our systems of cultural production. Friction defined in this sense can be broad: it refers to any force that slows down the speed of cultural production.
La cultura ha perso specificità e complessità per diventare digeribile dal mercato, e più che sprofondare in un vuoto deculturalizzato è immobilizzata nella stagnazione del suo stesso gioco di riferimenti: la cultura c’è, ma ha assunto la produzione di massa come paradigma, finendo per riprodursi attraverso infiniti souvenir, ricordi replicabili, miniature di se stessa. È il caso dei reboot e dei remake, delle infinite easter eggs che in alcuni casi sembrano essere più importanti del contenuto stesso di un’opera culturale, di una specifica qualità totalizzante che riesce a trasformare ogni forma di espressione alternativa in uno strumento di marketing, il recupero dei movimenti underground in una collezione di magliette fast-fashion, un album dalla copertina verde acido nel weltanschauung di una generazione.
In un numero della sua newsletter dedicato all’importanza del gatekeeping, ovvero della possibilità che alcuni contenuti e contesti siano meno accessibili al pubblico se non attraverso l’acquisizione di conoscenze e relazioni interne, Ruby Justice Thelot riflette sull’immediatezza culturale di Brat.
The “360” music video is an example of culture portrayed as something to be put on display, fully visible. Julia is everywhere, she is in the business of ubiquity. “Bratness” is not gatekept, it is accessible through consumption.
Una cultura souvenir, iper-ottimizzata e senza frizioni, è una cultura accessibile a tutti, anche se i riferimenti sono disseminati in modo da simulare una caccia al tesoro. Così come il turismo trasforma ogni espressione locale in un’attrazione di massa camuffata da esperienza autentica, allo stesso tempo la cultura contemporanea sfrutta i linguaggi e le pratiche delle nicchie per creare un’illusione di complicità con un pubblico in cerca di comunità. Storicamente, le easter eggs venivano celate nelle opere dai suoi autori per essere individuate solo dagli spettatori più attenti o dai giocatori più esperti. C’era il bisogno che il pubblico fosse in possesso di un certo codice, una chiave di lettura necessaria per riconoscerne l’identità e comprenderne il messaggio. Oggi questi indizi vengono preannunciati, pubblicizzati, esposti con un’aggressività che tradisce il bisogno di sfruttare il desiderio di appartenenza del pubblico per produrre hype e, auspicabilmente, vendite.
Il rischio della cultura souvenir è di restare intrappolata nel suo stesso gioco. Viviamo in un mondo che ha abolito il finale, in cui le tendenze muoiono a fine estate per resuscitare come zombie in autunno, in cui le regole del gioco sono dichiarate e nessun prodotto culturale ha il diritto di morire, perché potrebbe essere riutilizzato, remixato e riciclato da un momento all’altro, per questo attraversiamo la vita con l’impressione costante che il fantasma di un vecchio personaggio o la eco di una canzone del passato possano ripresentarsi da un momento all’altro all’interno di un nuovo contenuto.
Ha ragione Thelot quando suggerisce il ritorno del gatekeeping. Non si tratta di rendere la cultura esclusiva, ma di reintrodurre un grado complessità al suo interno, permettendo uno sviluppo multipolare e sfaccettato delle sue espressioni e dei suoi linguaggi, e ammettendo la possibilità che questi possano non essere sempre di facile lettura. Da questo punto di vista The Bear è in realtà un ottimo esempio, pur trattandosi di un fenomeno mainstream. Non si tratta di un prodotto inaccessibile, ma di un’opera che non sembra avere l’intenzione di chiarire subito le sue intenzioni allo spettatore, ricca di riferimenti pop ma anche di rimandi specifici che potrebbero passare inosservati a un occhio inesperto.
Per uscire dalla cultura souvenir serve un lavoro di deprogrammazione che si può fare solo a piccoli passi, magari provando a mettere il naso fuori dall’algoritmo di raccomandazione o contestare il concetto di creatività capitalista, cercando stimoli in contenitori apparentemente meno accoglienti, più opachi e impegnativi. Ammettere la morte di un personaggio e accettare che non lo si vedrà mai dormire sulla saracinesca di un ristorante gestito da una persona che non è suo figlio.
Una breve lista di letture ☕
Molly Yong ha messo i suoi nemici in ordine, dalla A alla Z, io li sottoscrivo tutti.
Un’analisi statistica del nostro rapporto con l’ascolto di musica nuova: quando sviluppiamo le nostre preferenze musicali, quando siamo più propensi ad apprezzare le produzioni mainstream e quando diventiamo dinosauri borbottoni e nostalgici. Io sono senza ombra di dubbio in quest’ultima fase, ma a quanto pare era statistico.
A proposito di musica: un articolo davvero interessante sul funzionamento dell’algoritmo di Spotify, le sue conseguenze, le possibili via d’uscita:
Perhaps the only way to escape our algorithmic bubbles is by building community. When we welcome diverse patterns of music consumption, we’re challenged to consider music from different perspectives, the same way independent radio stations curate to tell a story rather than cater to a demographic. There’s nothing to optimize in a community, and in turn, nothing to oversimplify.
How should a bookstore be? su The Baffler:
Bookstores are places that can interrupt the flow of publishing’s culture industry by showcasing books that customers might not otherwise see.
Videogiochi ed esistenzialismo su L’Indiscreto
A proposito di easter eggs, la mia preferita: in ogni episodio di Adventure Time è nascosta una lumachina che saluta 🐌
Prima di salutarci: il 29 sono a Industrie Fluviali con Edoardo Vitale e Irene Graziosi per parlare di lavoro. Fate un salto?
Ci sentiamo presto!