Ehilà 👋
Questa settimana Una goccia compie due anni :)
Volevo scrivere una cosa un po’ 🧀 ma poi ho cambiato idea. Però grazie, a chi legge e condivide, a chi mi scrive in privato per condividere le sue riflessioni, a chi si prende il tempo in un momento storico in cui pare che di tempo ce ne sia pochissimo. Vorrei dire big things coming soon ma chissà, mica è detto ❤
Intanto, se vuoi supportare questo progetto e il suo tentativo di rimanere interamente gratuito puoi cliccare qui sotto. In ogni caso, buona lettura!
Quando lavoravo nel settore pubblicitario, mi veniva spesso richiesto di pensare al marchio come a una persona. Per farlo, ogni volta che mi trovavo di fronte a un nuovo progetto (o a una richiesta di rebranding), mi era stato insegnato ad andare oltre le banali questioni di coerenza comunicativa e originalità estetica per rapportarmi al brand in modo da scorgerne il carattere invisibile nascosto tra le pieghe delle poche righe di brief che ci venivano consegnate.
Un metodo era quello di iniziare ponendomi domande semplici, la cui risposta si poteva facilmente individuare all’interno di un numero di opzioni limitato: se quel brand fosse stato una persona, che partito avrebbe votato? Quale sarebbe stata la sua serie televisiva preferita? Che gusti di gelato avrebbe messo in un cono piccolo? Man mano che trovavo l’orientamento all’interno dei quesiti più basilari, potevo iniziare a dirigermi verso ipotesi più complesse, che richiedevano formulazioni meno scontate: qual era il suo obiettivo nella vita? Come si sarebbe comportato in una situazione di pericolo? Qual era la sua attitudine verso l’amicizia, la carriera, l’occulto? E così via.
Il risultato mi sembrava sempre goffo, posticcio, poco credibile. Ma per qualche motivo ai clienti finiva per piacere. Chiudevano la call soddisfatti, sollevati dalla scoperta che potevano finalmente smettere di guardare al loro marchio come a un potenziale rischio imprenditoriale, e iniziare a considerarlo sotto una nuova veste. A metà della presentazione rivelavamo sempre il tratto saliente della personalità, che poi altro non era che uno degli archetipi junghiani semplificato per il marketing. L’effetto era quello di gender reveal o di un quiz di Buzzfeed: «Congratulazioni, il tuo marchio è un Eroe!» capitava di scrivere, oppure: «Ebbene sì, il tuo brand è un Fuorilegge nato!»
Anche se non mi piaceva lavorarci, perché mi sembrava sempre che il segreto per arrivare a un risultato decente risiedesse nella capacità di barare come si bara con una tavoletta ouija, ovvero decidendo già la direzione da intraprendere per poi fingere di esserci arrivati in maniera istintiva, fuori dallo studio pubblicitario il pensiero che i brand avessero una personalità mi procurava un certo conforto. Affidandomi alla stessa logica attraverso cui avevo imparato che tutte le persone cancro erano mie amiche mentre tutte quelle gemelli non lo erano affatto, potevo guardare al variopinto mondo delle merci con una chiave di lettura facile e rassicurante. E, di conseguenza, potevo leggere i miei bisogni e le mie scelte di consumo attraverso la stessa chiave. Stavo per acquistare quel completo della Nike perché mi serviva veramente o perché ero attratta dall’illusione che il suo messaggio di cambiamento, forza e coraggio (archetipo dell’Eroe) potesse migliorare nettamente le mie prestazioni? Non avevo davvero tempo di cercare un tavolo di legno al mercatino dell’usato o era il senso di appartenenza, semplicità e modestia espresso da Ikea (stereotipo dell’Uomo comune) a convincermi a varcare per l’ennesima volta la soglia dei suoi magazzini per poi uscirne con un mobile di truciolato standard?
Erano domande a cui avevo imparato a dare una risposta, a prescindere che questa poi ispirasse o meno le mie scelte d’acquisto, e tanto bastava. Oggi, che non lavoro più nella pubblicità e che qualcosa di più complesso e mutevole sembra essersi insinuato nelle identità dei marchi, so perfettamente che non sarei in grado di affrontare simili quesiti con altrettanta disinvoltura. Non saprei, ad esempio, dire con certezza perché abbiamo iniziato ad acquistare borse di alta moda a forma di packaging o prodotti agricoli, oppure perché un’istituzione museale come il MoMA abbia deciso di siglare un’edizione speciale di berretti da baseball. Quello che so è che mentre le nostre personalità (o perlomeno le loro estensioni digitali) sembrano essersi fatte un po’ più piatte, annoiate e dimesse, quelle dei brand sembrano sul punto di gonfiarsi, espandendo i propri confini oltre le strategie da manuale e le rigide prescrizioni di un archetipo junghiano, verso la ricerca di una qualità più sfaccettata attraverso cui esprimere una rilevanza non solo identitaria, ma temporale, culturale ed emotiva: non una personalità, ma un’aura.
Se l’aura fosse davvero morta con l’avvento dell’industria di massa e delle tecniche di riproduzione, come aveva inizialmente predetto Walter Benjamin nel 1936, sarebbe ancora più difficile spiegare il modo in cui, oggi, una certa rilevanza simbolica riesca a persistere negli oggetti che affollano la produzione contemporanea.
Un sedimento di aura, o un suo surrogato, continua a posarsi sugli artefatti profani e riprodotti che, di stagione in stagione, reputiamo significativi per la nostra biografia individuale e collettiva. Le nuove Crocs, i vecchi telefonini della Nokia, i packaging confortevoli e riconoscibili di una lattina di Coca-Cola o di una bustina di ketchup Heinz, una bottiglietta di plastica modellata per riprodurre la sagoma della madonna di Lourdes. Oggetti di consumo, souvenir, prodotti di massa. Se nell’epoca in cui Benjamin scriveva erano soprattutto le opere d’arte originali a generare la contemplazione dell’aura, oggi si tratta di un sottogruppo di artefatti non meno emblematici di un monumento per la memoria culturale del nostro tempo: icone pseudo-antiche di un’era meno digitalizzata in cui si guardava al futuro in technicolor; i prodotti si vendevano in riconoscibili confezioni colorate e l’esistenza era una sequenza di esperienze normali, prima che la normalità diventasse l’estetica del decennio. L’aura, oggi, pare essersi depositata proprio qui: all’intersezione tra merce e quotidianità, tra l’evanescenza di un logo e la tangibilità di un’esperienza reale. Attivata da un ricordo, un’impressione, che si manifesta attraverso cimeli di una vita ordinaria.
Nella nuova campagna firmata da Dani Coyle, il logo di Burberry si genera in maniera spontanea nel movimento della natura oppure assume forme diverse imitando oggetti e attività di piccola intimità domestica. Heaven di Marc Jacobs riproduce l’esperienza di una cameretta adolescenziale a cavallo tra i Novanta e i Duemila non solo attraverso la moda, ma anche realizzando eventi e attività estemporanee, come un libro di tattoo trasferibili o un’edizione limitata di peluche colorati. Poi ci sono i marchi che celebrano il prodotto per eccellenza di una vita ordinaria: il cibo. Industriale e confezionato, come la borsa ketchup di Kate Spade o quella a forma di scatola di sardine di Tommy Beaded, oppure immortalato nella sua semplicità, simbolo di un’esperienza tanto genuina quanto banale a cui il marchio affida il suo logo, come le melanzane di Loewe o il pane tostato di Jacquemus.
C’è chi dice quiet luxury e chi parla di ritorno della playfulness. Quello che mi sembra evidente è che l’aura ha finito per trasferirsi non solo dall’originale alle riproduzioni, ma anche dall’esclusivo all’ordinario. Più che trattarsi esclusivamente di una strategia di marketing, questo trasferimento appare come il riflesso di un nuovo sentire collettivo: non si tratta di semplice nostalgia o del ritorno del normcore, ma di una forma di scarsità che ha a che fare con la perdita di una normalità percepita con gli occhi di chi è cresciuto nel nuovo millennio. Lo spettacolo di un paesaggio naturale, tanto quello di una corsia del supermercato, è un’esperienza impermanente che si riattiva grazie ai loghi, i prodotti e le rappresentazioni dei marchi che entrano in dialogo con l’inconscio del consumatore, più che con i suoi bisogni diretti o con la necessità di affermare uno status.
Come spiegava Benjamin verso la fine degli anni Trenta, l’aura non è una costruzione interna di un artefatto culturale, ma il prodotto di uno sguardo reciproco: è il riconoscimento di un significato e di una rilevanza situati nell’incontro tra l’oggetto e il suo pubblico. Non esiste senza il nostro sguardo ma, al tempo stesso, non siamo noi a scegliere quale sarà l’oggetto che ci rimanderà quel bagliore inconfondibile. Non sorprende allora che l’aura si stia posando sempre di più sui simboli di una dimensione ordinaria che siamo finiti per contemplare, invece che vivere. Il banale diventa una categoria metafisica che definisce il ruolo dell’artefatto contemporaneo: segno di una mitologia del quotidiano, elevato a simbolo della nostra esistenza moderna.
L’aura non è più situata nell’originale (la Gioconda) ma neanche nella sua semplice rappresentazione (il foulard con la stampa della Gioconda): è nella ripetizione dei simboli che evocano la normalità come esperienza transitoria. Oggi l’aura è tanto nella confezione dei cereali Kellogg’s quanto nella busta di plastica di IKEA, negli ambienti audiovisivi familiari dei videogiochi e dei telefilm, nel complesso mondo di estetiche e vibrazioni che abbattono la dicotomia tra digitale e materiale, tra presente e passato, straordinario e comune, liberando queste categorie dal confronto morale per riconoscere il modo in cui, insieme, sono in grado di entrare nel tessuto della vita non come esperienze significative, ma abitudinarie. Siamo figli del consumo e dei marchi quanto del tempo e del luogo da cui proveniamo, creature che si accendono per un tramonto sul mare quanto per la perfetta riproduzione di un’alba in un videogioco, rapiti dall’armonia geometrica di un dipinto come dalla perfezione minimalista del logo di McDonald. A differenza degli archetipi junghiani e delle personalità, l’aura del banale non ci mette di fronte al problema di cosa stiamo acquistando, ma cosa stiamo perdendo.
Per questa volta niente link, ci sentiamo presto!
Se ti è piaciuto questo numero, puoi condividerlo cliccando qui 👇❤




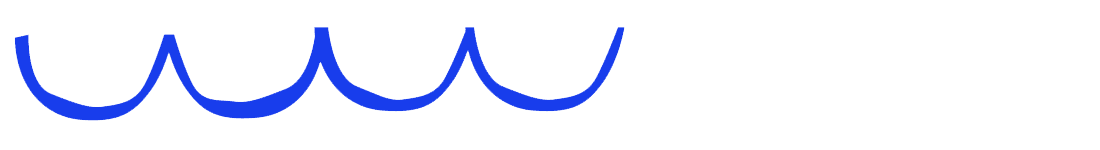




Buon compleanno alla newsletter e GRAZIE per il tuo lavoro, sempre illuminante.