Ciao a tutti/e 👋
Grazie a chi è arrivato/a nelle scorse settimane. Questa newsletter dorme da un po’ ed è bello vedere che c’è vita oltre il letargo.
Sono stati mesi di scrittura privata e di difficoltà a trovare un senso di quello che faccio in un contesto socio-politico sempre più spietato. Questo numero l’ho scritto anche un po’ per ritrovare il passo delle cose, nonostante tutto, riconoscere il senso di questo spazio come luogo di pensieri imperfetti e di riflessioni per forza di cosa marginali e parziali. Va bene così. In attesa di nuovi valichi.
Sul fondo dell’armadio in camera da letto, c’è una scatola di cartone che un tempo conteneva un paio di sneakers e che ora invece utilizzo per custodire la mia collezione di campioncini rubati negli hotel. “Rubati” non è il termine giusto, li offrono gratis, stanno lì apposta, allineati sui ripiani del bagno in attesa di essere trafugati. Non sono neanche tutti miei: alcuni sono regali provenienti da viaggi a cui non ho partecipato, ma di cui in qualche modo, grazie ai campioncini, preservo un ricordo di seconda mano. Sono souvenir di esperienze mai vissute o da tempo dimenticate, che ogni tanto mi diverto a rievocare inventando una storia attorno a ogni flacone, oppure lasciando che sia il packaging a suggerirmi un’ambientazione, la fragranza a evocare l’eco sbiadita di stanze in cui non ho mai dormito.
I campioncini sono intatti, non li ho mai utilizzati. Mi limito ad aprire la scatola di tanto in tanto per passare in rassegna i flaconcini accumulati, le loro confezioni satinate, i loghi troppo generici per ricordare la destinazione a cui appartengono. Ogni tubetto rinnova la stessa promessa, codificata in un linguaggio neutro e rassicurante, che rivela la vera funzione di questi piccoli omaggi: non la convenienza di una lozione gratuita, ma la possibilità di trovare un rifugio temporaneo dal mondo esterno immergendosi in una parentesi di benessere asettico, l’illusione che basti il sentore di una fragranza esotica per abitare, anche solo per pochi istanti, una versione più sostenibile della realtà.
Il fascino degli hotel è sempre stato questo: luoghi di transizione, spazi pensati per accogliere senza trattenere. La loro atmosfera neutra e discreta è frutto di una costruzione meticolosa, un arteficio in grado di attenuare il senso di spaesamento e trasformare una condizione provvisoria in un’esperienza confortevole, familiare a chiunque. I campioncini omaggio non sono un semplice servizio, ma parte integrante di questa messa in scena, di cui fanno parte l’arredamento curato senza risultare troppo caratterizzato, i servizi calibrati, le luci soffuse, le lenzuola eternamente inamidate; piccoli segnali di una cura che non è personale ma standardizzata, studiata per cancellare le differenze e far sentire chiunque a proprio agio, senza essere davvero a casa.
Retreat è la parola per questo tipo di spazi: ritiri, rifugi temporanei, piccole tregue dalla vita reale. Quello di ritiro è un concetto ormai ubiquo nella società occidentale, dove sempre più occasioni, prodotti e servizi si vendono non per ciò che aggiungono alla vita, ma per quello che si offrono di sottrarre: stress, ansia, noia, le immagini di un’esistenza ordinaria e quelle della violenza lontana che gli schermi trasmettono a ogni ora, disturbandola. Sono tutte cose da cui cerchiamo di ritirarci sistematicamente, al punto da aver trasformato il ritiro in una condizione mentale, un meccanismo interiorizzato da attivare attraverso l’aiuto di stimoli simbolici; campioncini di un benessere virtuale in grado di trasportarci in uno spazio mentale neutro, all’interno del quale stemperare l’identità e la sofferenza, allentare le connessioni con il mondo esterno, trasformare il presente in qualcosa da osservare, e non da abitare.
Esilio estetico è una definizione che ho trovato online e che mi sembra spiegare, almeno in parte, questo tipo di fenomeno. Nascondersi nel buon gusto, nelle cose giuste, nel piacere sedativo di ambienti e situazioni sociali caratterizzati da stimoli standard, senza contrasti o soprassalti di eccentricità. Affidare agli oggetti il ruolo di neutralizzare le nostre emozioni grazie alla combinazione di segni riconoscibili e impersonali al tempo stesso, attraverso cui distrarre i sensi e smussare i pensieri.
Non è un’idea nuova. Il consumo, con i suoi prodotti e i suoi spazi, ha sempre manipolato la realtà per offrire ai consumatori un senso di evasione. Ma l’idea di esilio, di ritiro, porta con sé un retrogusto di sconfitta: non ha più a che fare con la costruzione di immaginari alternativi o l’acquisto di paradisi possibili, per quanto fittizi, ma con un ripiegamento su se stessi, un rifugio in una tranquillità provvisoria e surrogata. Lontano, ma solo virtualmente, dall’incedere delle destre, dal tentativo di cancellare i diritti conquistati attraverso decenni di lotta, dall’orrore di un genocidio a cui possiamo solo assistere su piattaforme sempre meno accoglienti e stimolanti. Lontano dalla morsa degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale, dalla crisi climatica e dall’implosione della produzione industriale, mentre cerchiamo di sopravvivere senza neanche più il miraggio di una società dei consumi intimamente democratica e amichevole.
Ipernormalizzazione, invece, è il concetto sviluppato dal teorico e saggista Alexei Yurchak per descrivere l’ultima fase dell’Unione Sovietica, quando tutti, dal governo ai cittadini, sapevano che il sistema era ormai disfunzionale, ma continuavano a comportarsi come se il collasso non fosse imminente perché non riuscivano a immaginare alternative praticabili. Il termine è stato poi ripreso e ampliato dal documentarista Adam Curtis, che lo ha applicato alle società occidentali contemporanee, dove le strutture di potere, l’economia e la tecnologia creano una realtà artificiale, confortevole nella sua prevedibilità, anche se palesemente insostenibile.
L’esilio sembra un sintomo naturale dello stato di ipernormalizzazione. Più che una scelta, è una strategia di sopravvivenza: quando le alternative si fanno impensabili, l’unica risposta è il ritiro, la costruzione di micro-rifugi in cui ritrovare un margine di controllo.
Anche l’immaginazione, però, si fa sempre meno accesa, meno audace. Una ricerca risalente al 2020 del Science Museum Group Collection osserva come gli artefatti e i prodotti stiano progressivamente perdendo colore, mentre una newsletter di Dazed Magazine parla di great flattening, il grande appiattimento dell’immaginario veicolato dai marchi. Persino McDonald’s si è ingrigito, anche se in qualche angolo ottimista dell’occidente si sta cominciando a parlare di dopamine decor, ma il nome stesso tradisce la sua natura: non si tratta di entusiasmo genuino, quanto del tentativo di rianimare artificialmente un organismo in fase terminale. Il ciclo dell’immaginazione e della creazione sembra essersi inceppato anche a livello culturale, soffocato da un sistema che metabolizza ogni forma di dissenso e di immaginazione alternativa e la rigetta come prodotto di consumo. I marchi fagocitano le pratiche di comunicazione e coesione comunitaria con una velocità crescente, producendo un impatto sempre più effimero: un brand che pubblica una fanzine o si appropria del linguaggio culturale di una nicchia non è il segnale di un scambio di codici tra alto e basso, ma un gesto sterile, che invece di contaminare annienta, dissolve.
Qual è la differenza tra un mondo che continua a immaginare, a cercare soluzioni, e uno che si ritira allora? Il secondo assorbe ogni idea fino a svuotarla, riciclandola fino a trasformarla in uno stimolo minore, un souvenir culturale, il campioncino di un’esperienza che non esiste più. Tutto viene centrifugato e sterilizzato: il gesto artistico, l’espressione estetica, il linguaggio della protesta e quello delle sotto e contro culture, tutto diventa materiale d’archivio, pronto per la prossima collezione, per un nuovo format, un concept store. Un mondo che immagina, invece, non lo ricordo più tanto bene. Oltre la retorica nostalgica, al feticcio della memoria degli spazi comunitari, fisici e virtuali, che abbiamo vissuto ma che non esistono più, forse c’è il baratro, una fine non spettacolare che ci aspetta da lungo tempo. Forse, invece, c’è qualcos’altro. Di cosa si tratta, dobbiamo immaginarlo noi.
Newsletter correlate:
Ho finito lo spazio, alla prossima!












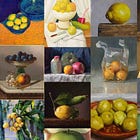
Come ho fatto fino a oggi a vivere senza questa nl? Ne parlavo con un’amica a Roma: tutti questi retreat (ritiri) sono il contrario di quello di cui abbiamo
Bisogno. Presenza e immaginazione, altro che ritiro. Anche se, dal punto di vista somatico, ha molto senso: è così troppo tutto, il vaso è così pieno (goccia!) che la capienza è colma. E al corpo non viene altra idea che staccare la spina della sua corrente elettrica (il
Sistema nervoso).
Bentornata <3
Stiamo sviluppando i primi anticorpi per questi anni bui, non siamo sole 🫂